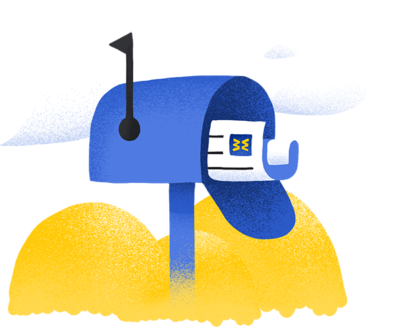Giornata mondiale della biodiversità 2025, la sopravvivenza dell’umanità dipende dall’equilibrio naturale, ed è quindi fondamentale promuovere uno sviluppo sostenibile che rispetti i limiti e i bisogni del pianeta. È questo il messaggio che arriva dalla ricorrenza in programma il 22 maggio.
Cos’è la biodiversità?
La descrizione più completa l’ha data l’ONU, definendo la diversità biologica come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono. Questa diversità si declina a livello genetico, di specie e di ecosistema.
Nel primo caso si intende la differenza dei geni all’interno di una determinata specie e, di conseguenza, la totalità del patrimonio genetico degli organismi che popolano la Terra. La diversità di specie è invece riferita all’abbondanza di specie presenti in un determinato territorio. Infine, la diversità di ecosistema definisce la quantità di habitat e di ecosistemi nei quali vivono e si sviluppano i diversi organismi.
Perché il 22 maggio è la Giornata mondiale della biodiversità?
È una data legata alla Convenzione per la Diversità Biologica e adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il 22 maggio 1992 nel corso del Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro.
A partire dal 2000 la si celebra ogni anno in tutto il mondo, allo scopo di diffondere la comprensione e la consapevolezza dei problemi che stanno mettendo a repentaglio la biodiversità (inquinamento, antropizzazione, cambiamenti climatici).
Il ruolo delle Nazioni Unite e COP 15
La Convenzione è un trattato internazionale giuridicamente vincolante che si pone tre principali obiettivi:
- la conservazione della biodiversità;
- l’uso sostenibile dei suoi componenti;
- una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche.
L’obiettivo finale, sottoscritto da 192 Paesi, è quello di incoraggiare azioni che porteranno a un futuro in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle prossime generazioni nel rispetto dell’ambiente e della sua ricchezza ecologica.
I lavori della COP 15 tenutasi a Montreal nel dicembre 2022 hanno sancito l’impegno, da parte dei Paesi sottoscrittori, a proteggere il 30% delle terre e delle acque ritenute importanti per la biodiversità entro il 2030 (attualmente sono protette il 17% delle terre e il 10% delle acque). L’iniziativa, definita Global Biodiversity Framework, prevede lo stanziamento di 200 miliardi di dollari.
Giornata mondiale della biodiversità 2025
“Armonia con la natura e sviluppo sostenibile” è il tema scelto per la Giornata mondiale della biodiversità 2025. Se da una parte la conservazione dell’equilibrio naturale è indispensabile per la sopravvivenza del genere umano, dall’altra lo sviluppo deve adeguarsi alle esigenze della Terra (e non viceversa). Ma vediamo perché la biodiversità incide così nel profondo sulla vita umana.
Il degrado degli ecosistemi incide sul benessere del 40% della popolazione mondiale, e compromette la disponibilità di risorse naturali e la capacità degli ambienti di svolgere funzioni vitali. La perdita di biodiversità, legata alla distruzione degli habitat naturali, favorisce la diffusione di malattie trasmesse dagli animali all’uomo: la pandemia di Covid-19, ad esempio, ha reso evidente come questi squilibri tra attività umane e sistemi naturali possano avere conseguenze dirette sulla salute globale.
Il ruolo dell’agroalimentare e della farmaceutica nella perdita di biodiversità
Ma c’è un paradosso: alcuni dei settori economici che dipendono dalla varietà biologica sono anche tra i principali responsabili del suo degrado. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, il sistema agroalimentare rappresenta la causa principale della perdita di biodiversità su scala globale.
L’86% delle specie a rischio di estinzione è minacciato da pratiche agricole che includono l’estensione delle monocolture, l’impiego di pesticidi e fertilizzanti e la conversione di aree forestali in terreni coltivati.
La biodiversità svolge un ruolo fondamentale anche nella ricerca farmaceutica dato che numerosi farmaci derivano da organismi naturali come piante, funghi e microrganismi, ma alcune pratiche del settore farmaceutico contribuiscono alla pressione sugli ambienti naturali. La raccolta non regolamentata di specie vegetali a scopo terapeutico è una minaccia per la conservazione degli habitat, con effetti negativi sulla stabilità ecologica, mentre l’inquinamento legato alla presenza di residui farmaceutici nei sistemi idrici ha un impatto sulla fisiologia e sulla capacità riproduttiva di numerose specie animali, alterando l’equilibrio degli ecosistemi acquatici. Queste criticità assumono ancora più rilievo se si considera che il pesce fornisce il 20% delle proteine animali a circa 3 miliardi di persone; che oltre l’80% dell’alimentazione globale dipende da prodotti vegetali e che una quota della popolazione rurale nei Paesi in via di sviluppo utilizza piante medicinali per soddisfare i bisogni sanitari di base.
Principali cause della perdita di biodiversitàPerdita e degrado degli habitat Sfruttamento eccessivo Cambiamento climatico Inquinamento Specie aliene invasive Malattie |
Proteggere la biodiversità: il piano c’è, l’impegno ancora no
Reagire? Sì, ma come? Come ricordato all’inizio di questo articolo, nel 2022 è stato adottato il Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal durante la COP15 (15a Conferenza delle Parti) della Convenzione sulla diversità biologica. L’accordo internazionale mira a fermare e invertire il trend, entro il 2030, attraverso il raggiungimento di 23 obiettivi principali. Tra questi c’è la protezione del 30% delle aree terrestri e marine; il ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati; la riduzione del 50% dell’uso di pesticidi e nutrienti inquinanti e l’eliminazione graduale dei sussidi dannosi per la natura, stimati in 500 miliardi di dollari all’anno.
A due anni dall’adozione del piano, la distanza tra impegni politici e risultati concreti resta significativa. Secondo il Protected Planet Report 2024, solo il 17,6% delle terre e l’8,4% delle aree marine sono protette, ben al di sotto dell’obiettivo del 30%. Meno del 5% delle aree terrestri protette dispone di una valutazione sulla gestione mentre per le aree marine la percentuale scende all’1,3%, evidenziando una carenza di dati sulla loro efficacia. Sul fronte finanziario, nonostante l’impegno a mobilitare 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030, le risorse effettivamente stanziate sono minime.
Azioni concrete per salvaguardare la biodiversità
Come è possibile operare nella realtà quotidiana avendo come fine la salvaguardia degli ecosistemi e la tutela della biodiversità? La Convenzione ha stilato un elenco di 22 azioni che ognuno di noi può mettere in atto. Vediamone alcune:
Pulisci un’area intorno a te
Che sia il tuo quartiere o la strada in cui vivi, rendi il tuo ambiente piacevole da vivere. E se non puoi farlo di persona supporta una ONG o un’organizzazione di volontariato.
Aiuta gli animali, grandi e piccoli
Se vedi un animale in difficoltà, chiama il rifugio per animali più vicino. Oppure sostieni economicamente i rifugi per animali selvatici e i centri di riabilitazione.
Pianta alberi (autoctoni), arbusti e piante
In questo modo si contrastano le specie aliene e si incrementano l’habitat e le fonti di cibo per la fauna locale. Non rilasciare animali domestici in natura, soprattutto se si tratta di specie non native.
Consuma responsabilmente
Dai la priorità all’acquisto di prodotti/alimenti a chilometro zero e realizzati senza danneggiare l’ambiente. Scegli prodotti con pochi imballaggi e ricordati di compostare eventuali scarti.
Sostieni le aziende amiche della biodiversità
Acquista i loro prodotti ed evita quelli di aziende che danneggiano la natura. Acquista prodotti biologici di stagione da piccole aziende agricole locali, sostenendo i loro sforzi per conservare la ricchezza biologica del territorio.
Riduci al minimo gli sprechi
Riduci i consumi inutili (“Ne ho davvero bisogno?”). E soprattutto riutilizza, ripara e ricicla, minimizzando ogni tipo di rifiuto. Non sprecare acqua.
Tutela della biodiversità e rigenerazione delle risorse naturali: cosa può fare la finanza etica
La finanza etica può fornire un importante contributo e offrire al tempo stesso risposte sostenibili in termini di crescita economica, salute e benessere. Gli investimenti ESG – attivi nei settori della finanza che mettono al primo posto l’ambiente (Environment), la società (Society) e il governo d’impresa (Governance) – sono l’applicazione del concetto di sostenibilità al mondo del business.
La finanza etica mette le persone e l’ambiente al centro della sua attività creditizia e di investimento, spostando in questo modo gli abituali metodi di valutazione economica (rapporto rischio-rendimento) anche e soprattutto sul piano etico e della sostenibilità.
Tra gli strumenti finanziari a disposizione della finanza etica ci sono i Green bond, noti anche come “obbligazioni verdi”. Sono nati nel 2007 e investono ad ampio spettro in progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente: produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili, uso sostenibile dei terreni, realizzazione di edifici eco-compatibili, trasporti a impatto zero, tutela dell’ambiente e della biodiversità, economia circolare, trattamento e riciclo dei rifiuti.
Perché il rischio di estinzione di massa è concreto
La perdita della biodiversità animale e vegetale è all’origine di quella che è stata definita, nel 2015, come la sesta estinzione di massa. Questa volta però, a differenza delle precedenti estinzioni, a innescarla è l’azione dell’uomo. Gli studiosi stimano che nel secolo scorso si sono estinte più di 500 specie di vertebrati terrestri, e un numero simile si prevede si estinguerà nel corso dei due prossimi decenni.
Gli obiettivi imprescindibili entro il 2030
I Paesi UE si sono impegnati a ripristinare la natura e la sua diversità. Sintetizzando in una frase: a salvaguardare il capitale naturale del pianeta. Nel maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato un piano strategico che prevede una serie di azioni da realizzare entro il 2030, come la creazione di zone protette sulla superficie terrestre e marina dell’UE, ampliando la copertura delle zone Natura 2000, il ripristino degli ecosistemi degradati entro il 2030 attraverso una serie di impegni e misure specifici, l’impianto di 3 miliardi di alberi e lo stanziamento di 20 miliardi di euro l’anno per la protezione e la promozione della biodiversità.
Il 27 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha approvato la legge sul ripristino della natura: un importante passo avanti verso il ripristino degli ecosistemi europei perché obbliga i Paesi membri a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell’Europa entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli ecosistemi danneggiati entro il 2050.
In Italia
Gli obiettivi europei sono stati recepiti nel 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica, che ha avviato la definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030. Il documento delinea una visione di futuro e di sviluppo articolata in due macro obiettivi strategici, a loro volta declinati in diversi ambiti di intervento: costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine; ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini. Una verifica dei risultati raggiunti è prevista per il 2026.
Servono azioni più incisive
Le iniziative presentate sopra costituiscono un primo passo, a cui ne dovranno seguire altri. Nel dossier sulla biodiversità messo a punto da Legambiente nel 2022 sono indicati una serie di campi di intervento che integrano e ampliano gli obiettivi europei e nazionali.
Tra questi vanno citati: l’incremento delle aree protette e delle zone di tutela integrale; garantire la gestione integrata della costa e il rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini; tutelare gli ecosistemi agricoli e l’agrobiodiversità delle aree ad alto valore naturale; aumentare la biodiversità forestale, creare foreste urbane e boschi vetusti; proteggere gli ecosistemi acquatici e migliorare i servizi eco sistemici dei corpi idrici superficiali; combattere le specie aliene invasive e dannose per la biodiversità.
Etica Sgr e l’impegno della finanza etica per la biodiversità
Per Etica Sgr l’investimento responsabile ha l’obiettivo di ottenere potenziali performance finanziarie positive e generare effetti positivi per l’ambiente e per la società. Scegliere i fondi etici vuol dire considerare anche l’impatto ESG dell’investimento e contribuire allo sviluppo di un sistema economico e finanziario più sostenibile e inclusivo, da un punto di vista ambientale e sociale.
Nel 2020 Etica Sgr ha firmato il Finance for Biodiversity Pledge, un’iniziativa promossa dalle istituzioni finanziarie parte della F@B Community dell’Unione Europea, per proteggere e ripristinare la biodiversità. Al momento del lancio, Etica Sgr era l’unica società italiana tra i 26 firmatari. Ad oggi sono 194 le istituzioni firmatarie, rappresentanti 23 trilioni di masse in gestione, che condividono le conoscenze, dialogano con le aziende e valutano l’impatto dei propri investimenti, fissando obiettivi specifici e rendicontando target e progressi. Attraverso questo impegno, le istituzioni finanziarie invitano i leader mondiali a invertire la tendenza dell’ultimo decennio per quanto riguarda lo sfruttamento ambientale e si impegnano a collaborare, attivarsi e calcolare il proprio impatto sulla biodiversità.
Nel 2022 Etica Sgr ha sottoscritto, insieme a circa ottanta investitori istituzionali di tutto il mondo, la Dichiarazione degli Investitori sul Cambiamento Climatico per sollecitare i governi ad attuare specifiche azioni politiche sul tema, inclusa la tutela della diversità biologica.
Etica Sgr oggi supporta anche Spring, la nuova iniziativa di PRI (Principles for Responsible Investment) delle Nazioni Unite, per preservare la biodiversità e contrastare la sua progressiva perdita. L’iniziativa Spring si concentra su attività di dialogo con aziende selezionate ed è volta a sensibilizzare e incoraggiare l’adozione, da parte di investitori istituzionali, di pratiche più sostenibili da un punto di vista ambientale. Etica Sgr, che è stata la prima società di gestione italiana a aderire al PRI nel 2009, sostiene questa iniziativa, in considerazione dell’importanza di un impegno congiunto tra investitori e aziende sul tema e per mitigarne i rischi economici correlati.
Si prega di leggere le Note legali.