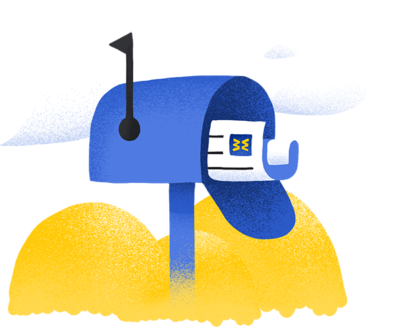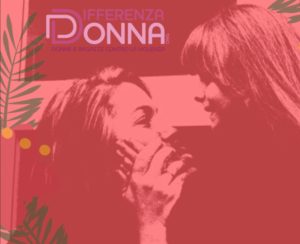La violenza di genere non è solo un fatto di cronaca: è una ferita profonda che attraversa la nostra società e continua a colpire donne di ogni età, contesto e provenienza. I numeri lo ricordano con forza: secondo Eurostat, una donna su tre in Europa ha subito violenza fisica. Dietro questa statistica si nascondono vite stravolte, opportunità perdute e un impatto che va ben oltre le vittime dirette. La violenza di genere causa costi sanitari, sociali ed economici enormi, riduce la partecipazione femminile al lavoro e mina la fiducia nelle istituzioni, frenando il progresso di intere comunità. Per questi motivi le Nazioni Unite hanno deciso di istituire la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. La ricorrenza, ogni 25 novembre, ricorda l’uccisione avvenuta nel 1960 in Repubblica Dominicana, delle tre sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), note attiviste politiche che lottavano contro la dittatura locale.
Le radici culturali e sociali della violenza di genere
La violenza sulle donne è un fenomeno universale, presente in contesti diversi e profondamente radicato in retaggi culturali difficili da sradicare. Tra le cause più ricorrenti vi sono le persistenti disuguaglianze di potere: differenze di status, ruoli e opportunità che continuano a riflettersi nella vita quotidiana. Si manifestano, ad esempio, in relazioni in cui uno dei partner esercita controllo economico o psicologico, oppure in ambienti di lavoro dove alle donne viene riconosciuta minore autorevolezza o minor accesso a posizioni decisionali.
Un’altra dinamica riguarda modelli culturali che, nel tempo, hanno premiato comportamenti improntati al dominio e alla forza, scoraggiando forme di dialogo, parità e gestione non violenta dei conflitti. In molti casi, questi modelli sopravvivono a livello implicito: basti pensare alla tolleranza sociale verso linguaggi svalutanti, alla tendenza a minimizzare i comportamenti aggressivi.
I fattori socioeconomici aggravano ulteriormente il quadro: la precarietà lavorativa, la dipendenza economica o la mancanza di alternative abitative possono impedire a una donna di lasciare una situazione pericolosa. Infine, la debolezza delle risposte istituzionali – procedure poco chiare, lentezza nelle misure di protezione o scarsa informazione sui servizi disponibili – finisce per scoraggiare molte vittime dal chiedere aiuto, alimentando un circolo di isolamento e rischio.

Una crisi globale: dati e tendenze preoccupanti
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 736 milioni di donne – quasi una su tre – hanno subito violenza da un partner intimo. Nel solo 2023, 51.100 donne e ragazze sono state uccise da un partner o familiare. Un fenomeno diffuso e ancora poco denunciato, che resta in larga parte invisibile. Come ricorda UN Women, la violenza nasce dove si interrompe il rispetto: verso le donne, la diversità e la parità economica e sociale.
Violenza di genere nell’Unione Europea: un fenomeno sottostimato
Il quadro europeo non è meno allarmante. Il rapporto Eurostat Violence experienced by total population (2025) mostra che:
- il 35% delle donne tra i 18 e i 29 anni ha subito una forma di violenza di genere;
- la percentuale scende al 24% tra i 65-74 anni;
- solo una donna su quattro denuncia o chiede supporto.
I Paesi nordici, come la Finlandia, registrano tassi di segnalazione più elevati grazie a una maggiore fiducia nelle istituzioni. Ma i numeri restano drammatici: nella nazione scandinava il 25% delle donne che hanno avuto un partner riferisce violenza fisica ripetuta. Neppure gli ambienti considerati regolamentati, come il lavoro, sono immuni: una donna su tre dichiara di aver subito molestie in ambito professionale.
Il caso italiano: un fenomeno strutturale
L’Italia non fa eccezione. Secondo i dati ISTAT, 2,4 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito violenza fisica negli ultimi cinque anni, pari all’11,3% del totale. I femminicidi restano la punta dell’iceberg: secondo i dati del Ministero dell’Interno (settembre 2025), delle 73 donne uccise dall’inizio dell’anno, 44 sono state vittime di partner o ex partner (60%); la percentuale sale all’83% considerando l’intera sfera familiare o affettiva.
Le risposte dell’Unione Europea: la nuova Direttiva sulla violenza contro le donne
Nel 2024 l’UE ha approvato la Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che introduce:
- il divieto e la criminalizzazione di mutilazioni genitali femminili e matrimoni forzati;
- la punibilità della condivisione non consensuale di immagini intime, dello stalking online, delle molestie e dell’incitamento all’odio di genere.
La Direttiva è stata accolta come un passo avanti storico, sebbene non sia stato raggiunto l’accordo sulla criminalizzazione uniforme dello stupro, elemento che ha generato critiche e richieste di maggiore ambizione.
I costi economici della violenza: 366 miliardi di euro l’anno
L’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE) stima in 366 miliardi di euro l’impatto annuale della violenza di genere nell’UE, di cui 289 miliardi relativi alla violenza sulle donne.
I costi includono:
- assistenza sanitaria e psicologica;
- servizi legali e giudiziari;
- perdita di produttività;
- danni a lungo termine sul benessere e sulla partecipazione economica.
Sempre più attenzione è rivolta alla violenza economica, forma di controllo che limita l’accesso delle donne alle risorse e al lavoro. Secondo l’ultimo report D.i.Re, della rete italiana dei centri antiviolenza, almeno un terzo delle donne accolte ha sperimentato – o continua tuttora a subire – violenza.
Parità di genere come moltiplicatore economico e sociale
Promuovere la dignità e la sicurezza delle donne significa generare valore. Le aziende e i Paesi che investono nella parità di genere mostrano migliori risultati in termini di governance, reputazione e innovazione e due recenti studi, l’UNDP Gender Equality Report 2024 e il HeForShe Impact Report 2025, considerano la parità come un moltiplicatore economico e sociale. L’HeForShe Impact Report 2025 evidenzia che oltre il 60% delle imprese globali analizzate ha adottato policy contro la violenza nei luoghi di lavoro: un segnale incoraggiante.
Investire sulle donne per costruire società più eque
L’azione istituzionale resta fondamentale, ma non sufficiente. Servono politiche di prevenzione e programmi dedicati a empowerment, educazione e inclusione economica. In questa prospettiva, l’UNDP Gender Equality Report 2024 segnala risultati significativi: oltre 300 milioni di donne hanno beneficiato di iniziative dedicate all’accesso ai servizi, alla leadership e alla protezione sociale; 140 milioni sono state supportate nella partecipazione politica e 137 milioni nell’accesso ai servizi essenziali. Investire nelle donne significa rafforzare comunità ed economie intere.
La finanza etica per la prevenzione della violenza economica di genere
Esiste una forma di violenza che non lascia lividi visibili, ma mina in profondità la libertà delle persone: è la violenza economica, quando il denaro, il lavoro o le risorse diventano strumenti di controllo e dipendenza. Da questa consapevolezza è nato Monetine, un progetto realizzato da Fondazione Finanza Etica insieme a Glocal Impact Network per il Gruppo Banca Etica, grazie al fondo utili di Etica Sgr.
Monetine ha l’obiettivo di aiutare le donne vittime di violenza economica a riconoscerla, contrastarla e superarla prendendo consapevolezza dei passi da intraprendere per riacquistare sicurezza in se stesse e la propria indipendenza economica.
Il progetto si articola come una piattaforma di attivismo civico e finanziario nata per dare strumenti concreti di educazione finanziaria e di empowerment alle donne in condizioni di vulnerabilità economica, oltre che fornire materiali e formazione specifica per le operatrici e gli operatori dei centri antiviolenza e per il personale bancario.
Monetine ha preso avvio grazie al bando “Mio il denaro, mia la scelta”, promosso dalla Fondazione Finanza Etica attraverso il fondo utili di Etica Sgr per finanziare strumenti di educazione finanziaria contro la violenza economica. Nella sua realizzazione, Monetine ha previsto tre principali destinatari: le donne vittime o potenzialmente vittime di violenza economica, le operatrici e gli operatori dei centri antiviolenza, e il personale bancario delle filiali del Gruppo Banca Etica.
Inoltre, sono stati sviluppati strumenti di comunicazione e sensibilizzazione — tra cui video-lezioni, opuscoli, campagne social e collaborazioni con influencer e attiviste — per portare il tema della violenza economica fuori dal silenzio, farlo conoscere e renderlo riconoscibile. L’obiettivo finale è duplice: da un lato, aiutare le donne a riconoscere, contrastare e superare la violenza economica acquisendo consapevolezza dei passi da intraprendere per riconquistare autonomia e indipendenza; dall’altro, stimolare una trasformazione culturale all’interno della finanza, affinché anche le banche possano essere parte attiva nel riconoscere situazioni di vulnerabilità e offrire supporto concreto.
Si prega di leggere le Note legali.