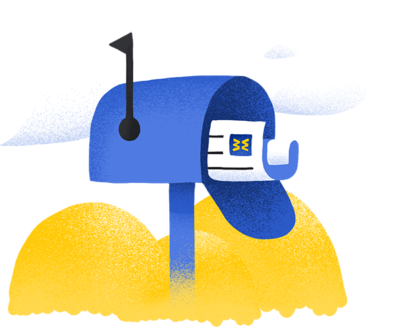In un mondo sempre più segnato da tensioni e conflitti, il settore degli armamenti – un tempo escluso dagli investimenti sostenibili per motivi etici – viene oggi sempre più spesso presentato come compatibile con i criteri ESG. Una tendenza che solleva interrogativi profondi: non solo per le gravi implicazioni sociali ed economiche, ma anche per i costi ambientali, ancora oggi poco conosciuti e insufficientemente discussi.
La corsa globale (ed europea) al riarmo
Il contesto geopolitico attuale è sempre più segnato da instabilità e conflitti. L’invasione russa dell’Ucraina e le tensioni crescenti in Medio Oriente, Asia e Africa hanno alimentato negli anni una corsa globale agli armamenti. Secondo il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), la spesa mondiale per la difesa, in costante aumento da oltre un decennio, ha raggiunto nel 2024 la cifra record di 2.718 miliardi di dollari, con un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente: si tratta della crescita annuale più elevata dalla fine della Guerra Fredda. Oltre 100 paesi hanno aumentato i propri investimenti nella difesa. Gli Stati Uniti guidano sempre la classifica con 997 miliardi, pari al 37% della spesa globale e al 66% di quella dei paesi membri della NATO. Europa e Medio Oriente registrano le crescite più marcate, confermando una dinamica generalizzata.

La crescita dell’esposizione dei fondi ESG nel settore degli armamenti
Questo scenario riflette un trend preoccupante sul piano finanziario: secondo un’analisi condotta da Morningstar Direct per il Financial Times, a settembre 2024 circa un terzo dei fondi in Europa e nel Regno Unito con focus su tematiche ambientali, sociali e di governance aveva investito 7,7 miliardi di euro nel settore della difesa, più del doppio rispetto ai 3,2 miliardi del primo trimestre del 2022. Un tempo escluso per motivi etici o reputazionali, il settore degli armamenti viene oggi in alcuni casi reinterpretato come “compatibile” con gli obiettivi ESG, soprattutto nel quadro della sicurezza europea e internazionale.
Durante la fase di massima espansione degli investimenti ESG, poche realtà avrebbero probabilmente osato argomentare a favore dell’acquisto di azioni o altri titoli legati ai produttori di armi. Oggi, complice una narrazione sempre più diffusa secondo cui finanziare la difesa equivarrebbe a sostenere la stabilità globale, molte barriere sono cadute. Questi fondi evitano ancora società produttrici di armi controverse (come mine antiuomo, bombe a grappolo e nucleari), ma in molti casi hanno smesso di escludere l’intero settore. Alla base di questo cambiamento vi sono da un lato le pressioni dei governi, dall’altro l’attrattività dei profitti offerti dalle aziende del comparto a fronte dell’intensificarsi dei conflitti.
L’impatto sociale del settore degli armamenti
Le guerre non si limitano a contare le vittime sul campo. Ogni conflitto distrugge ospedali, reti idriche, centrali elettriche, scuole e abitazioni. Questo impedisce l’accesso ai servizi essenziali e genera effetti di lungo periodo: fame, malattie, sfollamenti, crisi umanitarie e un drastico calo dell’aspettativa di vita. Le sofferenze non si fermano alle zone di guerra: il conflitto in Ucraina, ad esempio, ha avuto ripercussioni sul mercato globale del grano, aggravando la povertà alimentare in altri continenti.
La spesa militare, inoltre, è tra le meno efficaci in termini economici e occupazionali. Lo conferma l’ultimo rapporto Arming Europe di Greenpeace secondo cui l’aumento della spesa militare avviene a discapito di settori fondamentali come la sanità e l’istruzione, rallentando la crescita economica e aggravando le disuguaglianze sociali. Riorientare, quindi, le risorse pubbliche verso settori che generano benessere collettivo appare una scelta razionale prima ancora che etica. Investire in salute, istruzione e ambiente significa rafforzare la coesione sociale, ridurre le disuguaglianze e costruire una pace duratura.

L’ambiente, la vittima silenziosa delle attività militari
L’ambiente è spesso la vittima silenziosa delle attività militari, che producono effetti dannosi non solo durante i conflitti, ma anche in tempo di pace. Il settore della difesa ha un impatto rilevante sulle emissioni globali di gas serra: non solo per l’impiego diretto di armamenti, ma anche per la produzione, la manutenzione dei mezzi, le esercitazioni, la logistica e l’approvvigionamento, tutte attività che comportano un massiccio utilizzo di combustibili fossili.
La maggior parte dei paesi non rende pubblici i dati relativi al consumo di combustibili fossili a scopo militare, ma si stima che le attività militari contribuiscano in modo significativo alle emissioni globali di gas serra. Secondo il rapporto Less War, Less Warming, pubblicato nel novembre 2023 dai think tank Common Wealth e Climate and Community Project, le forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno emesso almeno 430 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente dall’anno dell’Accordo di Parigi sul clima – un quantitativo superiore alle emissioni complessive del Regno Unito nel solo 2022.
Un’ulteriore criticità riguarda la diffusione capillare delle basi militari nel mondo. Lo stesso rapporto segnala che le oltre 800 basi statunitensi e britanniche dislocate a livello globale comportano impatti ambientali rilevanti: dalla distruzione di ecosistemi alla perdita di biodiversità, dall’inquinamento acustico e luminoso alla contaminazione da PFAS, sostanze chimiche di sintesi nocive per la salute e in grado di contaminare l’ambiente per periodi molto lunghi a causa della loro elevata persistenza.
Durante i conflitti armati, l’impatto ambientale si intensifica. L’impiego di carburanti, l’utilizzo di esplosivi, i bombardamenti e gli incendi che colpiscono depositi, impianti industriali e foreste determinano un forte aumento delle emissioni. Secondo un rapporto pubblicato a fine 2023 dall’Osservatorio sui conflitti e l’ambiente, nei primi 18 mesi di guerra in Ucraina sono state immesse nell’atmosfera oltre 150 milioni di tonnellate di CO₂ e altri gas serra, un volume paragonabile alle emissioni annue di un paese industrializzato come il Belgio.
È importante ricordare che, anche al di fuori dei teatri di guerra, circa due terzi delle emissioni del settore militare derivano da operazioni di routine: tra queste spiccano l’utilizzo di aerei e navi da guerra durante le esercitazioni oltre alla produzione di armamenti, che genera un’impronta ecologica molto rilevante.
La posizione di Etica Sgr: gli armamenti non possono rientrare nella definizione di investimento sostenibile
In qualità di investitore responsabile, consideriamo estremamente preoccupante la crescita degli investimenti in società del settore degli armamenti all’interno di fondi ESG, soprattutto in un contesto geopolitico che spinge molti attori finanziari a cercare opportunità di profitto a breve termine in settori controversi, come gli armamenti.
La visione di Etica Sgr, invece, è orientata a un cambiamento duraturo e fondato su una prospettiva di medio-lungo periodo. Da sempre riteniamo che le armi, per loro stessa natura, non possano generare alcun tipo di impatto sociale positivo. Le guerre causano vittime civili, devastano il tessuto sociale, compromettono le economie e producono danni ambientali di enorme portata. Per questo motivo, adottiamo da sempre un approccio rigoroso che esclude dai nostri fondi l’investimento in armi sia convenzionali sia controverse, andando oltre la semplice esclusione di armi vietate da accordi internazionali, come le mine antiuomo e le bombe a grappolo.
La discutibile narrativa secondo cui l’industria della difesa dovrebbe contribuire a perseguire un obiettivo sociale – la protezione dei popoli – solleva perplessità alla luce di quanto previsto dal regolamento europeo SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). In particolare, l’articolo 2 stabilisce infatti che un investimento può essere considerato sostenibile solo se contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale senza arrecare un danno significativo a nessuno di tali obiettivi (principio DNSH – Do Not Significantly Harm).
Nel caso del comparto militare, questo requisito verrebbe strutturalmente meno. Oltre all’impatto sociale negativo, l’impatto ambientale dell’industria bellica è ampiamente comprovato da evidenze e dati. Per questo riteniamo che gli investimenti in società appartenenti al settore degli armamenti non possano in alcun modo essere considerati sostenibili.
Si prega di leggere le Note legali.