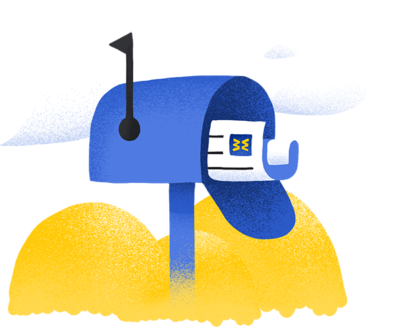Quando pensiamo alla guerra, la mente corre subito ai costi umani: vite spezzate, comunità distrutte, profughi in fuga. Accanto a questa tragedia evidente, ce n’è un’altra più silenziosa, che spesso rimane ai margini delle cronache: il costo ambientale.
Le guerre non si limitano a devastare città e infrastrutture. Colpiscono la terra, l’aria e l’acqua. Distruggono ecosistemi che hanno impiegato secoli a formarsi. Avvelenano i suoli con sostanze tossiche e rilasciano emissioni climalteranti. Gli effetti non finiscono con la firma di un trattato di pace: restano per decenni, spesso per generazioni.
Nel 2025, due rapporti autorevoli hanno riportato al centro del dibattito questa realtà:
- il National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ha pubblicato uno studio sugli effetti ambientali potenziali di una guerra nucleare, analizzando scenari di catastrofe globale;
- il Conflict and Environment Observatory (CEOBS) ha tracciato una mappa dei danni ambientali derivanti dai conflitti armati convenzionali, spiegando i meccanismi che degradano suoli, aria, acqua e biodiversità.
Questi due contributi, letti insieme, ci aiutano a comprendere l’ampiezza del problema: dalla deforestazione causata dalle operazioni militari alle nubi di fuliggine che un conflitto nucleare solleverebbe nell’atmosfera.
Emissioni militari e cambiamento climatico
Ogni guerra comincia ben prima del primo sparo. La produzione di armi, gli addestramenti, le esercitazioni e le logistiche globali degli eserciti consumano enormi quantità di combustibili fossili. Secondo CEOBS, le attività militari sono responsabili di circa il 5,5% delle emissioni globali di CO₂. Gli aerei da combattimento hanno consumi orari che superano di decine di volte quelli di un volo commerciale. Le navi da guerra, i carri armati, i convogli logistici: tutti alimentati da carburanti altamente inquinanti.
Oltre alle emissioni dirette, c’è un aspetto indiretto: le spese militari assorbono risorse che potrebbero essere destinate alla transizione ecologica. Più miliardi ai bilanci della difesa significano meno investimenti in energie rinnovabili, trasporti puliti, ricerca climatica.
Nel 2024 la spesa militare globale ha superato i 2.700 miliardi di dollari (SIPRI), con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Una cifra enorme che assorbe risorse che potrebbero essere destinate alla transizione ecologica.
Basti pensare che, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), per raggiungere gli obiettivi climatici servirebbero circa 4.000 miliardi di dollari l’anno in investimenti per energie rinnovabili e infrastrutture pulite. Ogni miliardo in più nei bilanci della difesa è un miliardo in meno per pannelli solari, eolico offshore, trasporti pubblici a basse emissioni e ricerca climatica.
Distruzione delle infrastrutture e contaminazioni tossiche
Le guerre trasformano le città in crateri. Le esplosioni liberano nell’aria polveri sottili, metalli pesanti, amianto. Fabbriche, raffinerie e centrali elettriche bombardate rilasciano idrocarburi e sostanze chimiche che contaminano il suolo e le falde acquifere.
Gli esempi non mancano:
- In Kuwait nel 1991, l’incendio di oltre 600 pozzi petroliferi appiccato dalle forze irachene sprigionò circa 1 miliardo di barili di greggio nell’atmosfera e nel suolo, oscurando il cielo per mesi.
- In Ucraina dal 2022, i bombardamenti su depositi industriali hanno sollevato nubi tossiche contenenti cloro e altre sostanze pericolose, respirate da migliaia di persone.
- In Siria, gli attacchi a impianti di trattamento delle acque hanno contaminato fiumi e bacini, aumentando i rischi sanitari per le comunità locali.
La guerra lascia inoltre sul terreno residui bellici: munizioni inesplose, mine antiuomo e ordigni chimici. Secondo l’ONU, oggi esistono oltre 60 Paesi contaminati da mine, che non solo mietono vittime civili ogni anno, ma avvelenano i terreni, rendendoli inutilizzabili per l’agricoltura e per la fauna.
Deforestazione e perdita di habitat
I conflitti armati distruggono foreste e zone naturali. Per creare basi militari o facilitare i movimenti delle truppe, vengono abbattuti alberi e devastati ecosistemi. La deforestazione legata alla guerra non è solo un danno ecologico: priva le comunità locali di risorse vitali come legna, frutta, acqua
Secondo CEOBS, in alcuni conflitti recenti si sono registrati tassi di deforestazione superiori al 10% annuo nelle aree interessate dalle operazioni militari. La deforestazione non è solo un danno ecologico: priva le comunità locali di risorse vitali come legna, frutta e acqua. Un esempio storico è la guerra del Vietnam, quando l’uso massiccio dell’Agente Arancio da parte degli Stati Uniti ha distrutto circa 2 milioni di ettari di foreste e contaminato terreni per decenni.
In alcuni casi, la distruzione è intenzionale: incendiare campi coltivati per affamare la popolazione nemica, abbattere dighe per inondare territori strategici, avvelenare fonti d’acqua. La guerra usa la natura come arma, e così facendo la distrugge.
Governance ambientale compromessa
Secondo l’UNEP (Programma ONU per l’Ambiente), nei Paesi colpiti da conflitti la governance ambientale può ridursi fino al 70% in termini di capacità amministrativa, lasciando vaste aree fuori controllo.
E anche dopo la fine dei conflitti restano enormi “debiti ambientali”: bonifiche da effettuare, ecosistemi da ricostruire, comunità da proteggere. In Iraq, ad esempio, si stimano ancora oltre 1.000 siti contaminati da idrocarburi e metalli pesanti a distanza di più di dieci anni dalla guerra. Ma non tutti i governi hanno risorse e competenze per affrontare simili sfide: spesso le popolazioni vivono per decenni a contatto con contaminazioni invisibili.
Il rischio di inverno nucleare
Una guerra nucleare non distruggerebbe solo città e infrastrutture: altererebbe il clima globale. Secondo il report del National Academies, le esplosioni nucleari su larga scala possono immettere nell’atmosfera fino a 150 teragrammi (milioni di tonnellate) di fuliggine derivante dagli incendi delle città bombardate. Queste particelle bloccherebbero la radiazione solare, abbassando drasticamente le temperature terrestri: il cosiddetto “inverno nucleare”.
Le temperature medie globali possono crollare anche di 5–10 °C entro poche settimane. Per avere un termine di paragone, l’ultima era glaciale, durata migliaia di anni, era caratterizzata da temperature globali più basse di circa 6 °C rispetto a oggi.
Gli effetti sarebbero planetari e immediati:
- riduzione delle piogge fino al 45% in alcune regioni agricole cruciali come l’Asia meridionale e il Sahel;
- collasso dei cicli agricoli globali, con cali della produzione cerealicola fino al 90% in pochi anni;
- rischio di carestie diffuse che potrebbero colpire oltre due miliardi di persone, secondo stime di modelli climatici.
Non si parla di pochi anni, ma di decenni di conseguenze, con interruzioni drammatiche della fotosintesi e della catena alimentare terrestre.
Fallout radioattivo e contaminazioni
Le esplosioni nucleari rilascerebbero radionuclidi nell’aria, nei suoli e nelle acque. Le particelle radioattive si depositerebbero ovunque, contaminando campi agricoli, foreste, fiumi. Gli effetti non si limiterebbero alla salute umana (tumori, malformazioni, infertilità). Gli ecosistemi stessi ne sarebbero stravolti: mutazioni genetiche, estinzioni di specie locali, alterazioni delle catene trofiche. Il fallout, a differenza delle armi convenzionali, ha una durata pluridecennale, con effetti intergenerazionali.
Effetti combinati con la crisi climatica
Un conflitto nucleare avverrebbe in un contesto già segnato da temperature record, siccità estreme e perdita di biodiversità. Le due crisi si sommerebbero amplificando i danni:
- ondate di calore e siccità aggravate da un improvviso raffreddamento globale, con oscillazioni climatiche destabilizzanti;
- acidificazione degli oceani già in corso, combinata con contaminazioni radioattive che colpirebbero catene alimentari marine;
- foreste già indebolite dagli incendi globali potrebbero subire danni irreversibili per contaminazione del suolo e ridotta fotosintesi.
Il risultato sarebbe un collasso simultaneo degli ecosistemi: la perdita di habitat chiave, dal Mediterraneo all’Amazzonia, potrebbe accelerare l’estinzione di migliaia di specie. Per le comunità umane, questo significherebbe scarsità di cibo, crisi idriche e un aumento esponenziale delle migrazioni ambientali, con decine di milioni di persone costrette a spostarsi in cerca di condizioni minime di sopravvivenza.
La posizione di Etica Sgr: gli armamenti non possono rientrare nella definizione di investimento sostenibile
In qualità di investitore responsabile, consideriamo estremamente preoccupante la crescita degli investimenti in società del settore degli armamenti all’interno di fondi ESG, soprattutto in un contesto geopolitico che spinge molti attori finanziari a cercare opportunità di profitto a breve termine in settori controversi, come gli armamenti. La missione principale della finanza responsabile dovrebbe essere indirizzare le risorse generate dal risparmio verso filiere generative e rigenerative, come l’economia sociale, le imprese virtuose e i progetti che garantiscono l’inclusione delle persone e la tutela degli ecosistemi.
Etica Sgr ritiene che le armi, per loro stessa natura, non possano generare alcun tipo di impatto sociale positivo. Le guerre causano vittime civili, devastano il tessuto sociale, compromettono le economie e producono danni ambientali di enorme portata. Per questo motivo, adottiamo da sempre un approccio rigoroso che esclude dai nostri fondi l’investimento in armi sia convenzionali sia controverse, andando oltre la semplice esclusione di armi vietate da accordi internazionali, come le mine antiuomo e le bombe a grappolo.
Oltre all’impatto sociale negativo, l’impatto ambientale dell’industria bellica è ampiamente comprovato da evidenze e dati. Per questo riteniamo che gli investimenti in società appartenenti al settore degli armamenti non possano in alcun modo essere considerati sostenibili.